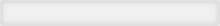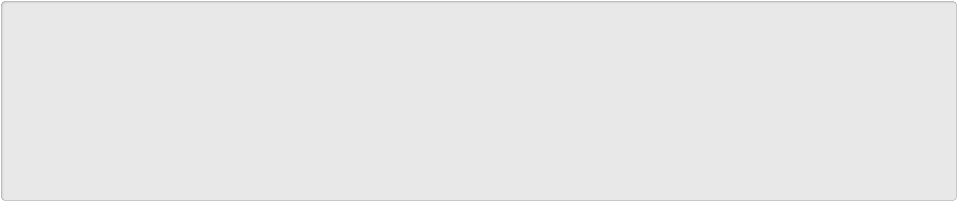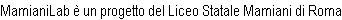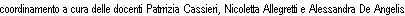Menu principale:
Collezione di matematica
Sezione: CALCOLO
COMPASSO DI GALILEI
Categoria principale |
Matematica |
Ambito |
calcolo |
Periodo |
inizio XXI secolo |
Numero inventario |
6 |
Dimensioni |
37 x 19 |
Materiali |
legno |
Costruttore |
Diego Urbani |
APPROFONDIMENTI
Museo Galileo, Firenze
DESCRIZIONE
Modello in legno di Compasso di Galilei realizzato per questo museo nell'ambito del Percorso Calcolare stanca.
È composto di due bracci mobili uniti a cerniera sulle cui facce sono incise varie scale numeriche. Tramite viti, dette galletti, ai fori praticati nei bracci del Compasso è fissato un quadrante graduato.
FUNZIONE
Non serve a disegnare circonferenze. Si tratta di uno strumento per l’uso civile e militare.
Le sette linee proporzionali tracciate sulle gambe del compasso e le quattro scale segnate sul quadrante, consentono di effettuare con estrema facilità ogni sorta di operazione aritmetica e geometrica: dal calcolo degli interessi, all’estrazione delle radici quadrate e cubiche, dal disegno dei poligoni al calcolo di aree, di volumi e quindi, almeno per corpi omogenei, anche la proporzionalità dei pesi. È quest’ultimo il problema di ambito militare per il quale Galilei ne propose l’uso.
Le potenzialità del Compasso derivano da una lettura intelligente del teorema di Talete sulle rette parallele, il nome gli deriva dalla forma, l’uso di opportune scale numeriche gli riconosce il ruolo di precursore del regolo calcolatore.
MODALITA' D'USO
Galilei ne "Le operazioni del compasso geometrico et militare" del 1606 descrive i molti usi del suo Compasso: Operazione II "come di una linea proposta possiamo prendere qualunque parti ci verranno ordinate " , Operazione IX è "come con l’istesse linee possiamo trovare la proporzione tra due figure superficiali tra di loro simili " , Operazione XXI "esplicazione delle linee metalliche notate appresso le stereometriche"….
Esempio
Per gli usi tecnico-militari Galilei ha inserito anche una scala in cui le divisioni sono indicate con i caratteri: Or., Pi., Ar., Ra., Fe., St., Ma., Pie. che significano Oro, Piombo, Argento, Rame, Ferro, Stagno, Marmo, Pietra.
Ad esempio per realizzare una palla da artiglieria di ferro di diametro B e peso uguale ad una di piombo e diametro A, si procede come segue:
si prende con un compasso la distanza A e si apre il Compasso fino ad adattare il diametro alla distanza tra i punti Pi. Pi. ;
la misura del diametro B cercato corrisponde alla distanza tra i punti Fe. Fe..
NOTIZIE STORICHE
L’esigenza di elaborare uno strumento in grado di eseguire calcoli aritmetici e operazioni geometriche era sentita soprattutto in campo militare dove la tecnologia delle armi da fuoco richiedeva sempre maggiori conoscenze matematiche. I primi compassi di proporzione furono realizzati nella seconda metà del XVI secolo, tra i quali il “radio latino” , il “proteo militare” e , appunto, “il Compasso geometrico e militare” di Galileo Galilei (1564- 1642).
Inventato a Padova nel 1597, lo strumento nasce dall’attività di Galilei in seno all’Accademia Delia, fondata nella città veneta per l’istruzione matematica dei giovani nobili destinati alla carriera militare. Galilei aveva a Padova una vera e propria officina nella quale valenti artigiani costruivano, secondo le sue disposizioni e sotto il suo controllo. Nel giugno del 1606 Galilei fece stampare, nella propria casa di Padova, dal tipografo Pietro Marinelli, 60 copie de “Le operazioni del compasso geometrico et militare”. Il testo è preceduto da una Dedica al giovane Principe Cosimo de' Medici (1590-1621), che Galilei istruì personalmente all'uso del Compasso, e da un Proemio ai Lettori in cui lo scienziato rivela particolari importanti della sua invenzione. Galilei istruì all'uso del suo compasso anche alcuni sovrani europei, quali il Principe Giovanni Federico di Alsazia, l'Arciduca Ferdinando d'Austria, il Langravio Filippo di Assia e il Duca di Mantova.Tra il XVII e XVIII secolo furono elaborate numerose varianti dello strumento che, con l’aggiunta di nuove linee proporzionali, ne estesero i campi di applicazione. Trattati furono scritti da Michel Coignet che lo chiamò “compasso pantometro”, da Muzio Oddi che lo chiamò “compasso polimetro”, da Ottavio Revesi Bruti che, dotandolo solo di linee proporzionali per il disegno degli ordini architettonici, lo chiamò “archisesto”, da Girard Desargues e altri matematici francesi che, dotandolo di linee proporzionali per il disegno prospettico, lo chiamarono “compasso ottico o di prospettiva”. Nel corso del XIX secolo, il compasso di proporzione fu gradualmente sostituito dalla diffusione dei regoli calcolatori che sopravvissero negli studi tecnici degli ingegneri, degli architetti e dei geometri fino all’avvento del computer. europei, quali il Principe Giovanni Federico di Alsazia, l'Arciduca Ferdinando d'Austria, il Langravio Filippo di Assia e il Duca di Mantova.
Tra il XVII e XVIII secolo furono elaborate numerose varianti dello strumento che, con l’aggiunta di nuove linee proporzionali, ne estesero i campi di applicazione. Trattati furono scritti da Michel Coignet che lo chiamò "compasso pantometro", da Muzio Oddi che lo chiamò "compasso polimetro", da Ottavio Revesi Bruti che, dotandolo solo di linee proporzionali per il disegno degli ordini architettonici, lo chiamò "archisesto", da Girard Desargues e altri matematici francesi che, dotandolo di linee proporzionali per il disegno prospettico, lo chiamarono "compasso ottico o di prospettiva". Nel corso del XIX secolo, il compasso di proporzione fu gradualmente sostituito dalla diffusione dei regoli calcolatori che sopravvissero negli studi tecnici degli ingegneri, degli architetti e dei geometri fino all’avvento del computer.